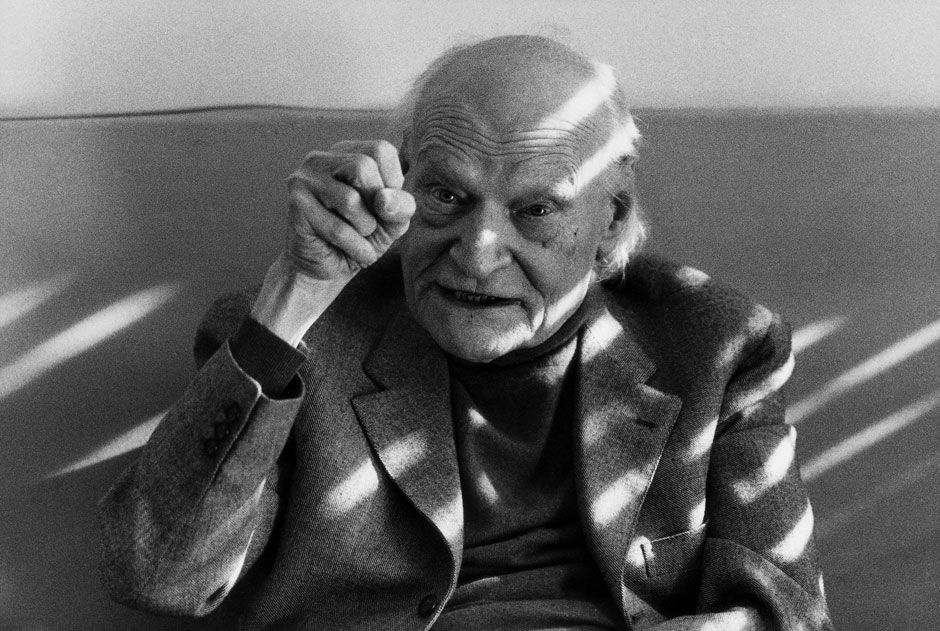Spesso, quando si parla di plagio, il campo artistico che viene immediatamente in mente è quello musicale. Del resto «le note sono sette» (cit.) e le melodie, orsù, potranno anche somigliarsi con tante canzoni nel mondo. Ma il vero settore in cui il plagio pare essere una inestirpabile deformazione (quasi) professionale è la scrittura. Tra giornalisti, ricercatori e scrittori, si fa fatica a tenere il conto dei casi in cui qualcuno, più o meno legittimamente, s’è impossessato delle parole altrui. Eppure il plagio letterario è anche uno dei meno trattati dai media. Basta ricercare su Google “plagi famosi” per accorgersi che nella prima decina di risultati, l’80 percento è dedicato ai plagi musicali. Anche perché c’è una strana teoria sulle scopiazzature letterarie: in fondo non sono così gravi, dicono molti. Come spiegava Marco Filoni su Il Fatto Quotidiano, già da tempi antichi c’è la concezione che il plagio letterario sia quisquilia. Elio Donato, grammatico latino famoso per esser stato maestro di San Girolamo, diceva: «Pereant qui ante nos nostra dixerunt», frase che i migliori latinisti avranno inteso significare, all’incirca, “che vadano al diavolo coloro che prima di noi hanno avuto le nostre idee”. La giustificazione del plagio è un’arte che, nei secoli, s’è affinata e ha raggiunto, soprattutto in ambito letterario, picchi mai raggiunti in altri campi, tanto da depenalizzare socialmente questo tipo di peccato. Sarà che, nella storia, i plagi sono tanti, svariati e pure famosi.
«Scrivere significa togliere le virgolette». Questa citazione appartiene a Roland Barthes, saggista e critico francese dei primi del ‘900, che a quanto pare la sapeva assai lunga. Luigi Mascheroni, su Il Giornale, ha infatti pubblicato un’interessante antologia di scopiazzature di alto rango, in cui si spiega che sono tanti i grandi maestri della penna che, nella loro mirabile carriera, sono caduti nella trappolona (poi sempre giustificata, chiaro) del plagio. Si va dal sommo Montale, che “prese ispirazione” da molti passi dei Frammenti lirici di Clemente Rebora o dagli scritti di Sandro Penna, a Melania Mazzucco, il cui romanzo pluripremiato Vita presentava intere pagine di Guerra e pace di Tolstoj. Premi giusti quelli ricevuti, visto che disse di non essersene nemmeno accorta. Campo assai ricco di plagi è quello della filosofia e maestro assoluto del tema è Umberto Galimberti, che sebbene pigro nella ricerca dell’originalità è stato un instancabile copiatore di idee altrui. Nel vizio della pigrizia ci cadde anche niente meno che Edmondo De Amicis, che nel 1871, quando il principe italiano Amedeo Ferdinando Maria di Savoia Aosta ascese al trono spagnolo, raccontò su La Nazione e poi in un breve volume intitolato Spagna, il suo viaggio iberico. Peccato che intere descrizioni e passaggi del suo scritto erano la traduzione letterale dell’opera Voyage en Espagne di Théophile Gautier. Probabilmente De Amicis non aveva tutta questa voglia di camminare e visitare la Spagna.
Per lavoro e per amore. Altri due insospettabili scopiazzatori della storia letteraria nostrana furono poi Luigi Pirandello e Giuseppe Ungaretti. A differenza di altri, però, loro copiarono per necessità, seppur diverse. Pirandello, ad esempio, poco dopo la pubblicazione de Il fu Mattia Pascal si trovava in una posizione economica precaria. Per questo agognava a una cattedra ordinaria all’Università in cui già insegnava. E per migliorare il suo curriculum necessitava di alcune pubblicazioni. Fu così che nacque il saggetto L’umorismo, che, probabilmente per la fretta nella sua stesura, presentava una mole di plagi non dichiarati enorme, come provò nel 2009 l’italianista Daniela Marcheschi. Ungaretti, invece, cadde nel peccato per amore: era il 1966 quando, in Brasile, conobbe la bellissima Bruna Bianco, poetessa di ben 52 anni più giovane di lui. Ma Ungaretti non si arrese innanzi alla differenza d’età e iniziò uno strenuo corteggiamento. Le cronache oggi ci riportano di un intensissimo scambio di lettere, mentre tacciono di altri tipi di scambi. Ma proprio in quelle missive si scopre che Ungaretti fece suoi versi appartenenti in realtà a James Joyce. Niente di così grave, se non fosse che poi le liriche dedicate alla bella e giovane Bianco vennero raccolte da Ungaretti in un piccolo volume, poi pubblicato.
Salgari, copiatore compulsivo, ed eredi. Nel 2000 fu invece smascherato il papà di Sandokan, Emilio Salgari. Un’italianista dell’Università di Hull, infatti, dimostrò che due degli 11 romanzi pubblicati sotto pseudonimo da Salgari sono in realtà plagi di semi-sconosciuti autori dell’Ottocento di lingua inglese. Perché farlo? La studiosa dice per necessità: all’epoca, infatti, il romanziere veronese aveva bisogno di soldi per assistere la moglie malata. Perdonato, quindi. Chi invece ha faticato non poco a farsi perdonare è stato Corrado Augias, ritenuto uno dei più grandi intellettuali italiani. Nel 2009 Augias volava sulle ali del successo del saggio, scritto a quattro mani con Vito Mancuso, Disputa su Dio e dintorni. Qualcuno, però, scoprì che le conclusioni di Augias a chiusura del libro sono identiche a una pagina dell’edizione italiana del saggio del celebre biologo Edward Osborne Wilson, La creazione (edito da Adelphi). Scoppiò la polemica e, alla fine, Augias dovette ammettere di aver “preso ispirazione” da una fonte anonima trovata nel web. Nelle successive ristampe del libro venne inserita la fonte, anche nella bibliografia.
Anche in Francia un sommo intellettuale dei tempi moderni è stato vittima del pubblico ludibrio da scopiazzatura (poi velocemente dimenticato). Si tratta di Joseph Macé-Scaron, giornalista di Figaro, direttore del mensile Le Magazine littéraire, direttore aggiunto del settimanale Marianne, conduttore della trasmissione Jeux d’épreuves per France Culture e cronista letterario per molte trasmissioni televisive. Non l’ultimo arrivato. Nel maggio 2011 pubblicò il libro Ticket d’entrée: ottima critica, grande successo, fino a quando una lettrice dichiara, in internet, che molti passaggi del libro sono incredibili plagi di un romanzo americano di Bill Bryson, Cronache da un grande paese. La polemica si è presto espansa, fino a che Macé-Scaron non ha potuto che ammettere: «Ho fatto una cazzata!» (letterale). Qualche intervista, un paio di scuse e poi il silenzio. Lo stesso silenzio che, ogni volta, va a sotterrare i plagi letterari. Come se, quando si scrive, fosse normale copiare senza citare. Anche perché poi, tanto, basta una giustificazione ben costruita per evitare la damnatio memoriae.