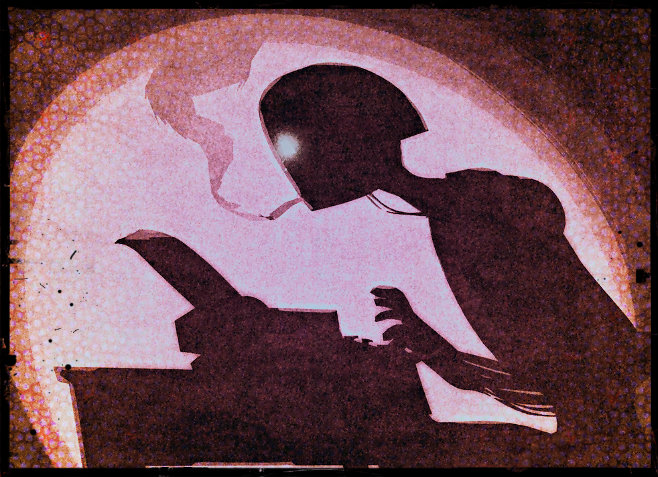Il 7 marzo, il The New York Times ha pubblicato sul suo sito web un quiz dal titolo curioso: “Lo ha scritto un essere umano o un computer?”. Esempio: «Un terremoto poco profondo di magnitudo 4.7 è stato rilevato lunedì a cinque miglia da Westwood, California, secondo quanto riferito dall’US Geological Survey. Il terremoto è avvenuto alle 6.25 a.m. ora del Pacifico, ad una profondità di 5.0 miglia».
Domanda: lo ha scritto un essere umano o un computer? Risposta: lo ha scritto un computer. Sembra incredibile, ma come riportato dal Nyt, «una scioccante quantità di ciò che leggiamo oggi non è creato da esseri umani, bensì da computer attraverso appositi algoritmi». Secondo alcune stime, entro 15 anni il 90% degli articoli di giornale sarà scritto dai computer. Gli algoritmi computerizzati, al momento, scrivono soprattutto report in un formato standard e relativi a fatti specifici. Nonostante ciò la cosa resta impressionante, anche perché, in realtà, i “robot scrittori” non si limitano a questo. Anzi, ce n’è per tutti i gusti.
Quando in sogno contemplo la tua ombra più bella,
quell’ombra che in sogno crea la mattina dormiente,
l’ombra del giorno del mio amore tradito,
presta alla ripugnante notte un sogno dalla forma sbiadita.
Ok, magari non è Shakespeare. Ma questa breve poesia l’ha scritta un programma computerizzato, creato da uno studente del Massachusetts Institute of Technology (MIT), J. Nathan Matias. Il giovane, sfruttando il funzionamento della popolare applicazione per cellulari Swiftkey (che analizzando le parole con cui si scrive un messaggio è in grado di imparare e predire il tuo stile di scrittura, suggerendoti la parola da inserire quando non ti viene in mente), ha creato Swift-speare, un’applicazione che offre un’interfaccia digitale per scrivere poesia. Una buona dose di cervello umano è ancora necessaria per fare sì che questi software funzionino al meglio, ma i passi da gigante compiuti nel campo dell’intelligenza artificiale fanno presagire che forse, in un giorno non molto lontano dall’oggi, poesie o romanzi interamente scritti da computer possano ambire a vincere addirittura premi letterari. È un po’ triste da pensare, e per qualcuno anche poco credibile, ma ciò non toglie che sia uno scenario quantomeno probabile.
Società leader in questo innovativo settore 2.0 è la Narrative Science, creatrice di Quill, programma capace di interpretare dati rilevando automaticamente le informazioni più significative, mettendole poi per iscritto in forma elegante. Tutto quel che ci rimane da fare è leggere. La società è stata fondata nel 2010 e ha sede a Chicago. Numerosi articoli di giornale, come ad esempio il report del terremoto proposto dal Nyt, sono oggi scritti via Quill. Prestigioso concorrente di questo software è Arria NLG (dove NLG sta per Natural Language Generation), che essenzialmente offre lo stesso servizio dal suo quartier generale di Londra. Applicazioni particolarmente utili di questi software si ritrovano in campo scientifico, dove l’uso di un linguaggio standard per presentare le informazioni, i dati e i risultati è fondamentale. Ci vuole molto tempo, umanamente parlando, per imparare a scrivere un articolo scientifico conforme agli standard imposti dalle riviste di settore, ma Quill ed Arria si propongono di risolvere il problema di apprendimento in pochi istanti. Ciò a patto che, logicamente, si decida di considerare l’apprendimento come un problema e non invece come un’enorme risorsa.
True Love è uno dei primi lavori di narrativa interamente generato da un computer. È un romanzo di 320 pagine pubblicato in Russia nel 2008, liberamente ispirato ad Anna Karenina di Leo Tolstoj per quanto riguarda la trama e allo scrittore giapponese Haruki Murakami per quanto riguarda lo stile. Qualche tempo dopo la sua pubblicazione, un professore della Insead Business School di Parigi, Philip Parker, ha creato un software capace di generare più di 200mila libri dopo che gli venivano immessi dati sui più svariati argomenti (saggi sui grassi nei formaggi, ad esempio). Darby Larson, ingegnere e scrittore, ha portato la questione al livello successivo, almeno secondo il magazine americano Vice: ha creato un software in grado di trasformare e mescolare insieme diverse frasi, generando quello che Business Insider ha definito «un interessante lavoro di arte letteraria». Nel 2013, la Harvard Books ha pubblicato il libro World Clock, programmato dal professore di media digitali del MIT, Nick Montfort. Ecco un breve estratto: «Sono esattamente le 05.00 a Samarcanda. In qualche sgangherata dimora una persona di nome Gang, che è po’ piccola di statura, legge una parola completamente inventata su una scatola di cereali. Poi gira tutto intorno».
Era il 1950 quando Alan Turing, il genio informatico di cui già vi abbiamo raccontato la storia (QUI), si chiedeva se le macchine avessero la capacità di pensare. Lui sosteneva che no, esseri umani e macchine funzionano in un modo completamente diverso. Probabilmente aveva ragione: la creatività umana non può essere sostituita da un groviglio di sofisticati algoritmi. Le macchine non diventeranno mai Shakespeare o Dante, per dire. Ma se l’adattamento è reciproco, se cioè anche noi umani ci adattiamo al modo di ragionare dei computer, allora è probabile che cominceremmo ad apprezzare veramente un lavoro di narrativa scritto da una macchina. Ma sarà, in ogni caso, un piacere generato da una sofisticata rete di combinazioni matematiche logiche e complesse, nulla a che vedere con la letteratura, misterioso anfratto dell’arte che ancora ci fa venire i brividi d’emozione.