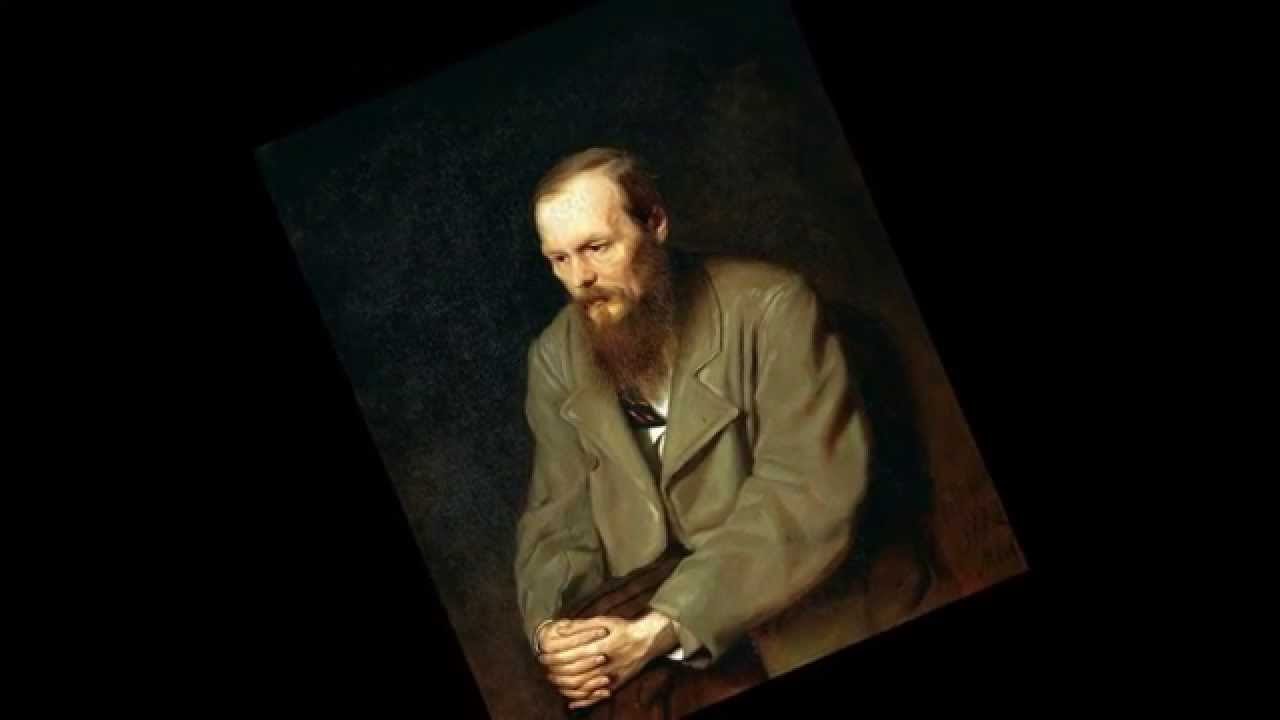Il 23 aprile 1849 Fedor Dostoevskij veniva arrestato con l’accusa di essere membro di una società segreta tesa alla sovversione sociale e politica della Russia zarista. Era vero? Se lo meritava? Alla prima domanda potrebbero rispondere gli storici, alla seconda persone da cui conviene guardarsi. Fatto sta che quattro anni ai lavori forzati in Siberia, Fedor, se li prese. Il suo viaggio per la fortezza di Omsk, nel cuore delle nevi siberiane, ebbe inizio il giorno di Natale del 1849, per concludersi l’11 gennaio successivo. La deportazione fu spaventosa, percorsa a temperature intorno ai 40 gradi sotto lo zero e madida della disperazione di chi è atteso dal nulla della “casa dei morti”, come chiamerà la sua prigione nel 1863 in Memorie dalla casa dei morti.
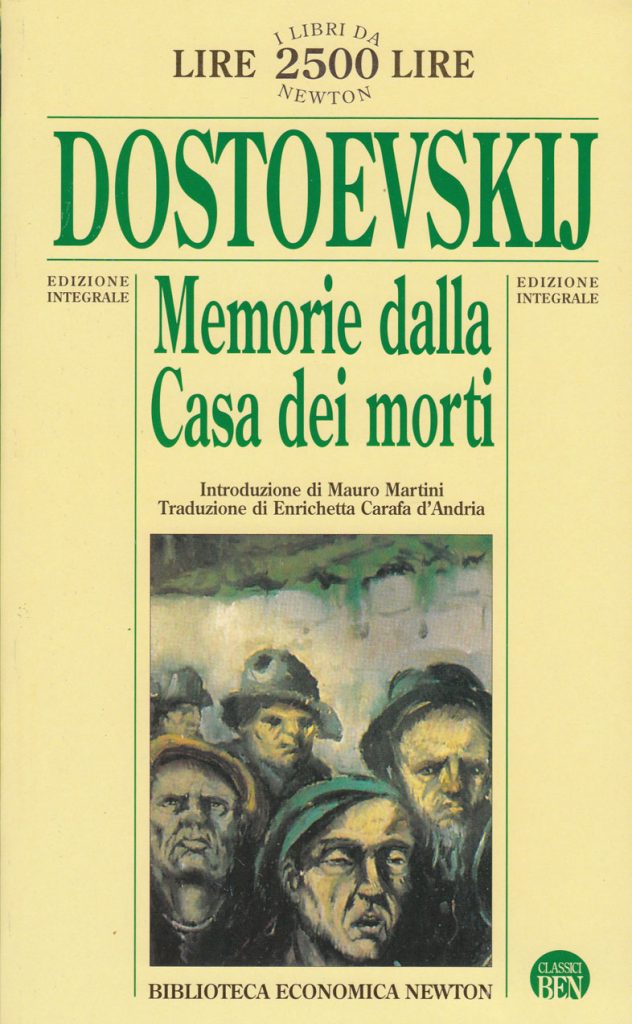
L’arrivo a Omsk. Ad accoglierlo certamente non ci furono modi garbati, moine e comodità: spogliato e privato di qualsiasi effetto personale, venne buttato nudo su un tavolaccio, dove avrebbe dovuto passare la sua prima notte da carcerato. Fedor si guardò intorno, e la stretta al cuore fu lancinante: uno stanzone lungo e angusto, reso ancor più soffocante dalle candele di sego che emanavano quel poco di luce sufficiente a guardarsi e ricordarsi di essere ancora degli uomini. Sacrificare l’ossigeno per la coscienza di sé, forse, era un tributo che occorreva pagare per non perdersi definitivamente. Ad arredare il tremendo salotto, la più vasta casistica umana che si potesse immaginare: gente che rideva, che piangeva, che non si capiva se ridesse o piangesse, che giocava a carte, che urlava a non si sapeva chi; falegnami, calzolai, sarti, le mani di tutti tese non per accogliere ma per stringere ancor di più la morsa intorno al cuore di Fedor: «Quale periodo spaventoso. Fu una sofferenza indicibile, interminabile, perché ogni ora, ogni minuto pesava sulla mia anima come una pietra».
La vita in carcere. Dostoevskij non era mai solo, affiancato costantemente da compagni della medesima sorte o da carcerieri, ma si sentiva comunque più abbandonato che mai: nessuno con cui parlare, nessuno con cui condividere, nemmeno un libro a cui affidare il ritmo della giostra del proprio sempre più delirante pensare. Pensare, in effetti, era tutto quanto gli rimaneva. Nella sua testa, Fedor inscenò in quegli anni un duro processo alla sua vita passata, allestendo un tribunale di cui fu spesso grato, perché gli permise di mantenere un’ancora con la vita vera. È paradossale come ciò che Dostoevskij, in quegli anni, avvertisse come più autentico fosse ciò che era infinitamente lontano. Stranezze da vita carceraria.

Al mattino e fino a sera, tutti i giorni, il lavoro: dietro la fortezza correva un fiume gelato, sul quale i detenuti demolivano navi in disuso, e quando erano fortunati si occupavano di far girare la ruota nel tornio. Ciò che Fedor soffriva di più non era tanto la fatica in sé, quanto il fatto che fosse obbligato a lavorare. Anche provare a scambiare quattro parole con gli altri detenuti era un’impresa: si parlava, ma solo come se la vita fosse iniziata dal primo giorno di prigionia. Ciò che era accaduto a ciascuno prima della condanna era assoluto tabù. E quando per caso qualcuno si lasciava sfuggire un dettaglio, era quasi meglio che non fosse accaduto: Gazin, un alto e robusto russo, negli anni precedenti provava un particolare piacere nello sgozzare bambini. «Non avevo, accanto a me, quasi un solo essere con cui potessi scambiare una parola cordiale. Mi sentivo bandito, tagliato via dal mondo».
La libertà. Il pensiero fisso, martellante e indomabile, era naturalmente quello della libertà. Ne cercava tracce ovunque, soprattutto nell’aria primaverile, quando respirandola a pieni polmoni tentava di cogliere le fragranze lontane, oltre le mura, dell’assenza di catene. Riversò ogni sua speranza nella fede: tentava in ogni modo di cogliere sempre più la figura di Dio, ritenuta così profonda e perfetta. Andava in chiesa due o tre volta al giorno, quasi esclusivamente per sentir dire al sacerdote le parole liturgiche “Accoglimi come il ladrone, Signore”.
L’ultimo periodo di carcerazione fu del tutto diverso. Intravedere la fine della prigionia e scorgere finalmente l’alba della libertà lo riempiva di gioia e di un nuovo vigore. Ebbe anche la possibilità di avere finalmente dei libri, il primo dei quali lo divorò pressoché in un’unica notte. La sera prima dell’agognato giorno fece un giro delle mura, come già aveva fatto migliaia di volte, ma in quel momento aveva tutto un altro sapore. Andò a letto presto, si alzò ancora prima, e dopo aver salutato gli altri detenuti andò alla fucina per farsi spezzare le catene, simbolo ultimo della libertà perduta per quattro anni. «La libertà – commentò Dostoevskij –, una nuova vita, la risurrezione dei morti».