C'è un gene che protegge dal dolore (è cosa nuova e non da poco)

Gli insetti, in particolare i moscerini della frutta, insegnano. Almeno in tema di dolore. Mappando il DNA di questi animaletti alati, infatti, un’equipe di ricercatori del Children’s Hospital di Boston, negli Stati Uniti, avrebbe individuato una variante genetica in grado di controllare la sensibilità alla sofferenza cronica e acuta. Che il dolore racchiudesse in sé anche una componente ereditaria era cosa nota da tempo alla scienza, ma non era ancora chiaro se, fra i geni che accendono la miccia del dolore, alcuni fossero maggiormente implicati di altri e con quale intensità. Almeno fino ad oggi. Una scoperta, quella americana, che potrà dare avvio alla creazione di nuovi farmaci analgesici per le terapie del dolore.
La ricerca. Il lavoro è stato lungo e oneroso, perché gli scienziati hanno dovuto analizzare quasi 12 mila geni, ricercando soprattutto le mutazioni che interessavano le cellule nervose e, fra queste, quelle specifiche del dolore. Così l’ingente quantità di corredo cromosomico è andata via via diminuendo e i ricercatori si sono ritrovati a dover scandagliare solo 600 geni. A quel punto, occorreva identificare se fra di essi ve ne fosse qualcuno capace di stimolare, acutizzare o controllare gli accessi dolorosi.
E, poiché l’impegno e la dedizione premiano, i ricercatori ne hanno identificato uno, chiamato alfa2 delta3, che sembrerebbe in grado di garantire il funzionamento dei canali del calcio. Ovvero le vie che le cellule nervose sfruttano per avviare la propria eccitabilità elettrica. Proprio la variazione di questo gene, dimostrata sui moscerini appunto e poi anche sui topi, spigherebbe il meccanismo di insorgenza del dolore e la successiva capacità di controllo.
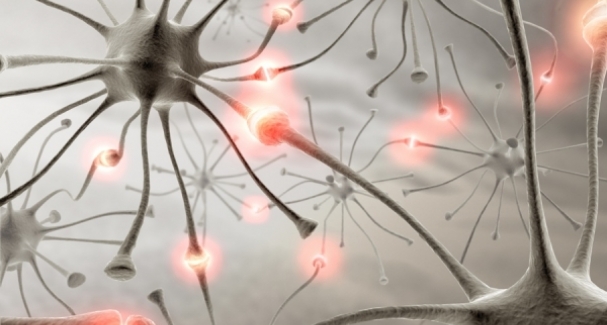
Gli esperimenti. Un’ipotesi non basta per fare scienza. Va comprovata da esperimenti che ne attestino la veridicità, la validità e poi l’applicabilità nella pratica clinica. E così, dai laboratori, l’esperimento di controllo genetico del dolore è passato sull’uomo. I ricercatori hanno radunato quasi 200 volontari e li hanno sottoposti al test del calore, che intendeva capire se e come il gene alpha2 delta3 fosse attivo anche nell’uomo, se dipendesse da una sua variante e se questa fosse protettiva contro gli accessi dolorosi.
Sebbene la risposta sia risultata positiva a questo primo test, i ricercatori, non ancora soddisfatti, hanno esteso la sperimentazione altri 169 pazienti, tutti in cura per il dolore causato da ernie ai dischi vertebrali, testati con un diverso esame, che si è rivelato essere la prova del nove. In conclusione, la serie di ricerche ed esperimenti avrebbe dimostrato che i fortunati pazienti portatori di questa variante genica non soffrissero o fossero meno predisposti a sviluppare un dolore cronico insistente, quello cioè che perdura oltre sei mesi e che non risponde di norma a terapie farmacologiche.
Informazioni preziose che verranno sfruttate dai ricercatori per comprendere le basi genetiche del dolore e identificare fattori di rischio per il dolore cronico, utili alla creazione di nuovi analgesici e al miglioramento del processo decisionale circa l’idoneità del trattamento chirurgico nei casi in cui la terapia medica non sia sufficiente a sedarlo o non dà risposta.

I geni stoici. Quella americana è un’informazione in più che si aggiunge al panorama scientifico già noto in materia. Era già stato scoperta, infatti, l’esistenza di geni stoici, quattro in tutto, che consentono a chi li possiede di avere una soglia di tolleranza al dolore più o meno alta, dipendente appunto dalla diversa presenza di questi geni nel proprio Dna.
Alcuni ricercatori di Proove Biosciences, una società anch’essa statunitense che si occupa di medicina personalizzata, li avrebbe individuati tenendo sotto osservazione quasi 3mila persone, tutte con una diagnosi di dolore cronico e trattate con farmaci oppiacei, ma soprattutto esaminando il loro patrimonio genetico.
Avrebbero così scoperto che a regolare l’intensità (bassa, media e alta) alla tolleranza al dolore, in una scala da 0 a 10, sarebbero i geni codificati come COMT, DRD2, DRD1 e OPRK1. E più precisamente il gene DRD1 sarebbe stato associato a una bassa tolleranza al dolore, la coppia di geni COMT e OPRK darebbe la capacità di sopportare moderatamente la sofferenza fisica, mentre la variante DRD2 sarebbe quella più stoica di tutte. Consentirebbe cioè di avvertire meno il dolore e di sopportare meglio anche accessi importanti e perduranti.
Anche in Italia si studia il dolore. Fra i tanti in corso, il progetto dell’Istituto neurologico Besta di Milano ha meritato un ingente finanziamento da parte della comunità europea. È volto a scoprire le alterazioni genetiche alla base del dolore neuropatico, ossia il dolore che insorge come conseguenza di una patologia o di una lesione del sistema somatosensoriale, che è l’insieme di nervi che trasportano gli stimoli dalla pelle fino al cervello.
Non tutti i pazienti con un danno a carico dei nervi sviluppano dolore, e non tutti con la stessa intensità. Il progetto intende capire la ragione di questo strano meccanismo di risposta al dolore, andando a ricercare e identificare alcune mutazioni genetiche che si verificano in particolare nei canali del sodio e in grado di spiegare la presenza di dolore in pazienti che soffrono di una neuropatia periferica senza causa nota.