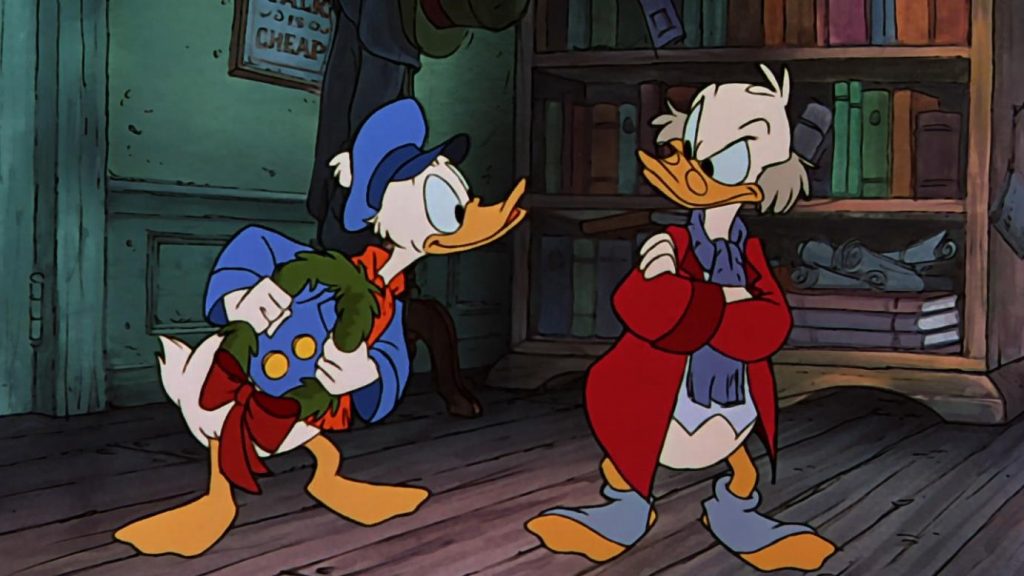Ogni volta che viene Natale siamo da capo. Il bambino che è nato povero; i suoi rifiutati dall’albergo – anche loro perché erano poveri; la stella che si posa sulla capanna e via di seguito.
Fortunatamente il cuore di Santa Madre Chiesa è largo più d’ogni larghezza possibile e immaginabile, e quindi permette che ciascuno si figuri la scena a modo suo, compresi i modi più bizzarri. Pensando che il bambino fosse biondo, ad esempio. O la storia della cometa, che i Magi se l’eran persa per qualche tempo e invece noi la mettiamo fissa.
E la interpreti anche, a modo suo. Da qui la stupefacente fioritura di rappresentazioni scritte, musicate, dipinte, scolpite, in ceramica, su arazzo, cinematografiche e televisive di quella notte. Alcune delle quali davvero stupende, c’è poco da fare.
Alle quali vanno poi aggiunte le storie, le poesie, le filastrocche, i cinepanettoni che si occupano non dell’evento originale, ma dei giorni legati alla festività che la ricorda: “Natale” nel senso di “Vacanze ‘di’ o ‘a’ (Cortina, Caraibi, Katmandu o dove altro volete) o di “Cena (o pranzo) di”. Zampognari, presepe, messa di mezzanotte, tombola, neve e quant’altro.
Questo secondo filone di opere è interessante perché fa capire cosa abbia prodotto la presenza di quel fatto unico e antico nelle diverse società e nei diversi climi culturali: ma spesso si tratta di narrazioni così distanti dal nucleo della faccenda da far storia a sé.
Fuga dal Natale di Graham Greene – un titolo per tutti – non mette a tema la volontà di allontanarsi dalla fede, ma solo l’insofferenza che il protagonista prova nei confronti del bailamme connesso con la ricorrenza. Non per nulla nell’Angelus di domenica scorsa papa Francesco ha accennato al fatto che gli stessi preparativi per il Natale possono trasformarsi in un modo per dimenticare, per censurare l’essenziale.
Il racconto Tutti i giorni Natale, di Heinrich Böll, non contiene l’esortazione a far sì che il Bambino nasca nel nostro cuore – come dicono a messa – ogni giorno, e non soltanto il 25 dicembre. È una terrificante satira del delirio cui può portare il fatto di aver imbalsamato la festa nel suo stereotipo borghese e tedesco.
Ci sono poi le storie dei buoni, come se la festa dovesse di per sé spingere tutti a diventare testimonial di una famosa pasticceria industriale tanto fortunata da potersi giovare senza sforzo alcuno dell’assonanza al pinocchiesco paese dei balocchi. Natale nel senso di: “fate i buoni, bambini!” Lo Scrooge di Dickens, che diventa generoso perché è Natale, si inserisce in questo filone.
Per non parlare delle infinite leggende nate per spiegare le bacche rosse dell’agrifoglio o altre scempiaggini del genere. Zucchero e melassa.
Ci sono però alcuni elementi, nel racconto di Luca – ossia nella sceneggiatura originaria – che potrebbero indurci a riflettere. Più per quel che non viene detto che per quel che vi si può leggere nero su bianco.
Cominciamo con la storia che Giuseppe e Maria dovettero deporre il bambino nella mangiatoia perché non c’era posto in albergo. D’accordo: può essere una metafora del mondo che rifiuta la presenza di Cristo. Ma anche no: presentatevi in un cinque stelle a Cortina alle dieci e mezzo del 24 dicembre (la Vigilia); andateci pure col Cayenne o con la Lamborghini e chiedete al concierge una matrimoniale con lettino. Se è completo, vi diranno cortesemente di cercare altrove. Dove pensa che potremmo trovare una stanza? Non saprei, signore, siamo un po’ tutti nella stessa situazione. Nessun rifiuto preconcetto, nessun oltraggio alla povertà. Semplicemente non c’è posto.
Erano poveri, Maria e Giuseppe. Chi l’ha mai detto? Certo: la tradizione li vuole poveri, perché ha proiettato un valore spirituale sui dati storico-anagrafici. Ma Giuseppe, dicono i vangeli, era “della casa e della famiglia di David”, ossia la più nobile che si potesse immaginare. Un Windsor, un Asburgo, un Hohenzollern in altre parole. Pare anche che un lavoro ce l’avesse: faceva l’artigiano, che al tempo non era un lavoro da poco. Perché mai avrebbe dovuto essere povero? Non tutti gli artigiani sono come Geppetto o come il ciabattino delle storie antiche. Anche i grandi mobilieri o i grandi costruttori sono artigiani.
Nessuno ricorda mai, invece, il fatto che – proprio perché di famiglia nobile e dunque conosciuti – marito e moglie dovessero prendere armi e bagagli per andare a compilare un modulo a 160 e passa chilometri da casa. Roba da prendere l’imperatore per il collo e fargli ingoiare una risma di carta e qualche timbro.
Erano poveri. Ma se pochi giorni dopo arrivano quelli da non si sa dove – i Magi – e gli portano dell’oro (non avranno fatto tutto quel viaggio per portargli solo una catenina o una medaglietta. Gli avranno portato almeno un lingottino, si suppone. Magari due). E poi incenso (con quel che costava allora) e mirra da camparci per un anno almeno, si pensa. Dice che sono immagini per indicare la regalità (l’oro), la vita santa (l’incenso) e l’immortalità (la mirra si usava per ungere i corpi dei defunti). Vuol dire, allora, che gli hanno portato tanta di quella roba da camparci bene fino ad una età avanzata. Tanto è vero che, saputo che le cose si stavano mettendo male, Giuseppe portò la famigliola in Egitto. E oggi lo sentiamo tutti i giorni che quelli che sono rimasti nelle zone dove impazza l’Isis ci sono rimasti – dicono loro – perché non hanno i soldi per andarsene, come hanno fatto quelli più ricchi. Dunque: Giuseppe i soldi li aveva. Di suo e per donazione.
Perché abbiamo insistito su queste ipotesi alternative? Per nessun’altra ragione che per rispettare il comandamento che vieta di farsi immagini di Dio. Non siamo iconoclasti: tutte le riproduzioni del presepio ci commuovono. Siamo come san Francesco che voleva baciare le dita a tutti i sacerdoti perché toccavano il Corpo Santo di Gesù. Ci incantano le Natività e le Adorazioni dei Pastori da Lorenzo Monaco a Caravaggio e su su fino all’ultimo pittore della domenica.
Ma il Natale, il racconto del Natale, è così scarno, è così accaduto a telecamere spente, è successo così senza che nessuno se ne accorgesse, che ogni immagine – vogliamo dire: ogni idea, ogni rappresentazione mentale – che ce ne facciamo ne riduce il silenzio, la potenza infinita. È venuto, Gesù, anche per tutti coloro che odiano compilare i moduli, per quelli che non hanno potuto prenotare a tempo e adesso si trovano nei casini e la moglie gliel’aveva detto che non si sentiva bene, ma hanno voluto lo stesso andare a St. Moritz e ora, lo vedi Tarcisio? non c’è più una camera e tocca tornare a Poschiavo, o addirittura a Tirano.
Col fatto di essere così secco, col fatto di aver scritto così poco, Luca ci ha permesso di inoltrarsi nell’infinito non detto di quella notte, che è diventata, per questo, così brulicante di possibilità da illuminare davvero ogni cosa, compreso il fatto di dover perdere del tempo e correre dei rischi inutili per la burocrazia. O dover risalire in macchina e mettersi a cercare un albergo – anzi, l’ospedale, perché le si son rotte le acque. E il sedile è in pelle, mannaggia. Ma fa niente, perché Gesù è nato.